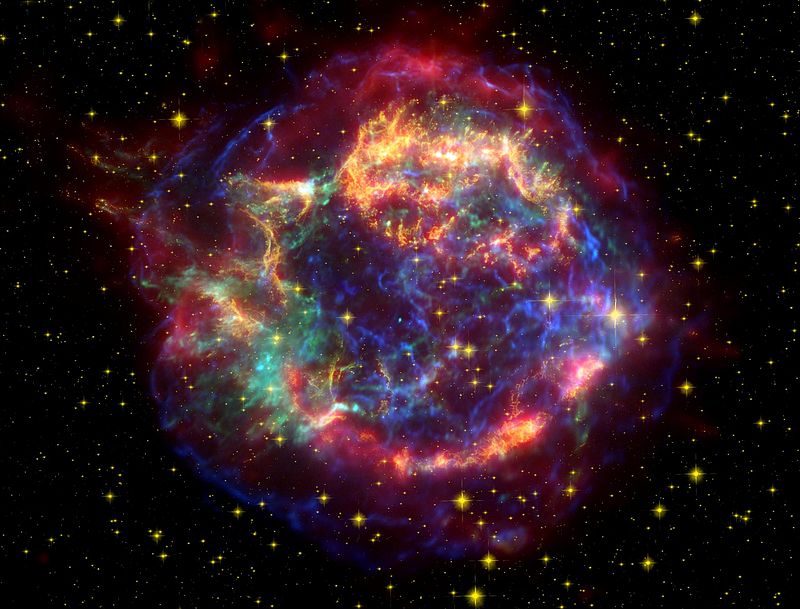
In questo periodo sono incappata (non si incappa mai in realtà, è questo il tema di oggi) nel tema delle coincidenze, o meglio, delle sincronicita, come amano dire i guru.
Quel qualcosa per cui tu balli e l’universo ti porta…
Una trentina di anni fa, all’università, mi innamorai di medicina legale. In realtà mi innamoravo un po’ di tutto, una specie di puttana curricolare insomma. Ma la medicina legale fu un vero amore , non solo un flirt. Il professore ordinario era un uomo monumentale, serioso, dalla voce e dagli occhi che sapevano troppo. Un gigante severo, di quelli che ti fanno venire voglia di imparare tutto solo per il gusto di sentirti approvata da loro. All’esame presi trenta e lode, con la domanda per la lode che sfido chiunque altro ad averla saputa. Quella lode fu una carezza ruvida che non ho mai dimenticato.
Quando arrivò il momento di scegliere davvero, però, non ce la feci e mi tirai indietro.Scappai, lo ammetto, davanti all’idea di avere a che fare con i bambini morti.
O forse era solo una scusa. Forse, banalmente, preferivo i vivi.
Più impegnativi, certo, ma almeno a volte guariscono. O ti ringraziano. O ti raccontano storie, anche assurde, e tu puoi ancora ridere, ascoltare, discutere.
Così la medicina legale restò lì, in un angolo della mia storia. Come quelle passioni giovanili intense ma impraticabili, che non rinneghi mai del tutto.
Poi, come accade a chi ha l’anima piena di “prima o poi lo farò”, un giorno mi sono iscritta a un corso di teatro ( vedere post precedenti …). Era da una vita che ci giravo intorno. Prima il lavoro, poi la famiglia, poi la stanchezza. Ma quest’anno no. Quest’anno è stato diverso.
Mi ci sono buttata con la leggerezza di chi ha smesso di cercare scuse.
Tre insegnanti, tutti diversi. Ma una in particolare: quella che mi fa un po’ più ridere, ma solo perché ha un modo di far ridere che mi risuona, che tocca quelle mie corde di bimbetta che ride per “cacca culo” e per il gioco “chi ride prima perde”, e al tempo stesso a cui scappa qualche coltissima citazione che immancabilmente non colgo, ma soprattutto quella di cui annuso la ruvidezza di chi ha dovuto tappare un po’ troppi buchi dell anima. Una di quelle persone che ti chiedi che vita abbia avuto, cosa che a me peraltro capita poco, perché , purtroppo o per fortuna, raramente la gente mi incuriosisce. Può sembrare snob , probabilmente lo è, lo sono. Ma di base a me di che fanno o pensano gli altri non me ne frega una beata cippa (lippa).
Insomma, ieri scopro che è la figlia di quel professore.
Sì, proprio lui.
Quel gigante della medicina legale, quello della lode, quello dei bambini morti.
Ho sentito una leggera scossa.
Non è una coincidenza. È un punto che si chiude. Una porta che si riapre. È come se il passato mi avesse fatto l’occhiolino, travestito da presente.
Ora non studio medicina legale. E non so recitare (ancora). Ma mi sento perfettamente nel mio copione. Anzi, a tratti mi pare quasi che qualcuno lo stia scrivendo con me. Con un discreto stile peraltro.
E quindi universo, balliamo, conduci tu…




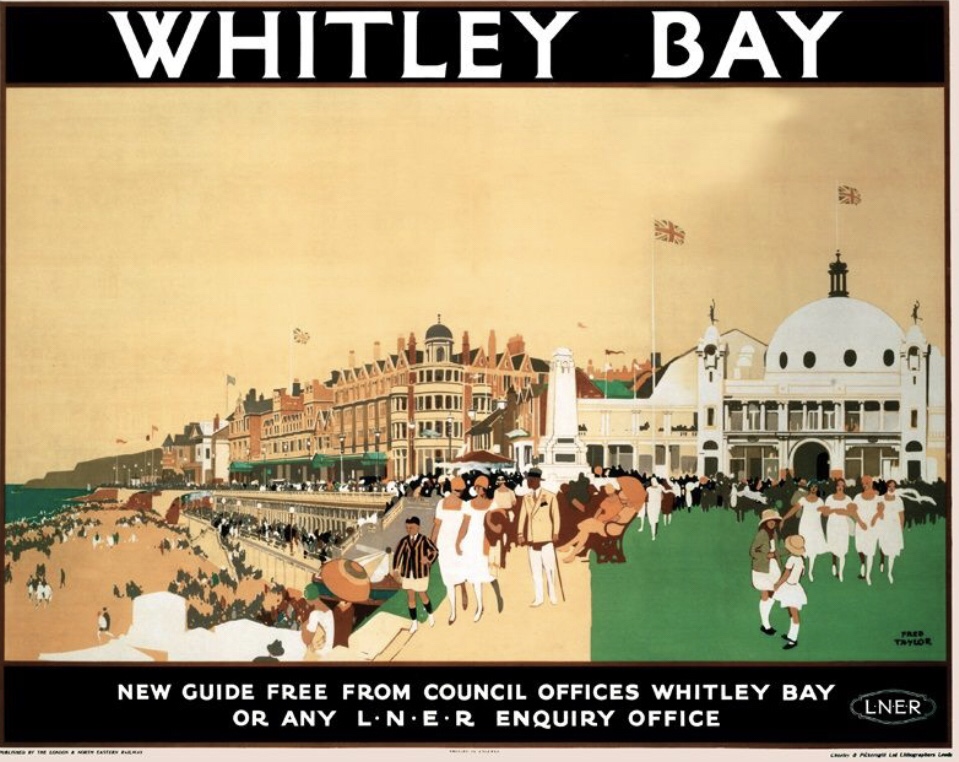




 Oggi è stata una giornata interessante in ospedale.
Oggi è stata una giornata interessante in ospedale.